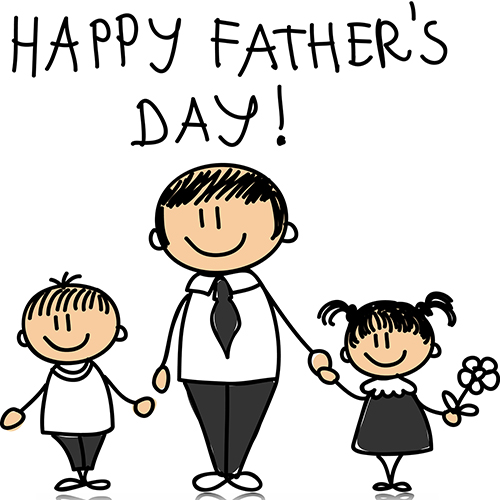Domenica pomeriggio. Esco a comprare delle cornici per foto che ho trovato a casa dei miei, sto collezionando oggetti-ricordo che fra un po’ non mi faranno più entrare in casa.
Scendo per la via principale che porta alla piazza e, sulla sinistra, vicino ai portici, c’è una macchina parcheggiata con targa estera.
Una famigliola è intenta a smontare le bici, immagino dopo una gita, prima di tornare in hotel.
Nei pochi metri che mancano ad incrociarli immagino le loro vacanze, sono pochi passi, ma la pellicola mentale riesce a costruire una piccola storia.
Poi, arrivo al loro fianco e il film diventa un horror.
Il papà, alto, giovane e snello, tira un pugno violentissimo sulla spalla del figlio più grande. Un ragazzino di circa dodici anni che, spaventato, lo guarda in un modo che non scorderò facilmente.
E’ la forza del pugno a convincermi che non sta scherzando, ma fatico a crederci.
Nello sguardo ci sono mortificazione, dolore, sorpresa, vergogna, sfida, scherno, mortificazione, vergogna, dolore.
Uno sguardo disperato alla ricerca di un sentimento da mettere a fuoco.
E, invece, un caos emotivo che sento anche io e che mi addolora.
Mi fermo, li guardo. Purtroppo, il signore non si gira. Potrei intervenire, ma io stessa ho paura.
Improvvisamente, il papà ne tira un altro, di pugno. Un altro.
Sempre nello stesso punto.
Tanto per essere chiari.
Il bambino ha i lampi negli occhi.
Io resto immobile, altri si girano, nessuno dice niente.
Tutto quello che diciamo e facciamo ai nostri figli diventerà quello che loro faranno e diranno ai loro, e agli altri.
Tutto quello che siamo, loro saranno.
Quell’uomo, probabilmente, ha ricevuto, nello stesso modo, quei pugni lì.
E li restituisce.
Ha imparato quella scorciatoia violenta che toglie le parole, che toglie l’amore.
E la usa.
È difficile cambiare.
Ciò significa che i nostri gesti non sono buoni o cattivi solo nel momento in cui li compiamo.
Rimangono nell’aria, nel mondo, nella vita.
Non si cancellano e se crediamo che quelli cattivi si cancellino non è vero.
In realtà rimangono sotterrati e spingono con violenza per potere uscire e liberarsi. Diventano il nostro bagaglio pesante e silenzioso e, senza accorgercene, li ripetiamo. Restano a farci male.
Essere adulti è una responsabilità enorme e penso che mi piacerebbe fosse data a ciascuno la possibilità di rendersene conto e di scoprire, letteralmente, che cosa possiamo fare con i bambini per farli stare bene e cosa, invece, li fa soffrire.
La possibilità di capire cosa ci accade quando perdiamo la via e, pur intuendo l’errore, non riusciamo a fare diversamente.
Bisogna farsi aiutare.
Perché quando si guardano gli altri (come oggi è capitato a me) è facile, mentre se sei tu il protagonista diventa molto difficile.
Sì, bisogna farsi aiutare.